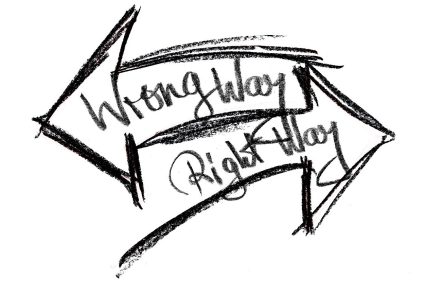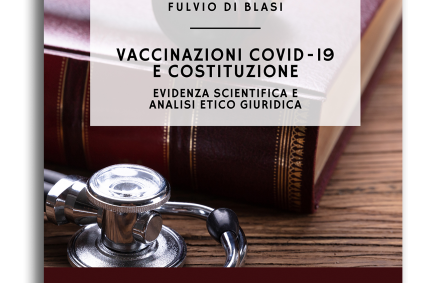QdB – Questioni di Bioetica 3/2008
di Marianna Gensabella Furnari*
La definizione di eutanasia comprende già in sé un’interpretazione del problema[1] ed è proprio per questo suscettibile di cambiamenti, secondo i contesti di riferimento. Una prima differenza può ricavarsi dal contesto storico e dal primo significato a cui, secondo l’etimologia, la parola eutanasia rinvia. La “buona morte” non implica la problematicità del significato attuale del termine, che è riconducibile al “procurare intenzionalmente la morte”, ma rinvia solo alle modalità in cui la morte “avviene”, modalità ritenute “buone”[2]. La morte è l’evento che tutti temiamo più di ogni altro, o meglio la morte è il “non-oggetto” di fronte a cui non possiamo dire di provare paura, ma qualcosa di più radicale, l’angoscia che ci coglie quando siamo ai confini del “ni-ente”[3], quando l’alternativa tra l’essere e il nulla non è più per noi un problema del pensare, ma una duplice, tragica possibilità che grava sulla nostra esistenza. E’ possibile che questo evento accada in modalità che l’esistente giudichi “buone”? Come può essere “buona” l’Assoluta Signora di hegeliana memoria? Poiché della morte nulla sappiamo[4], se non che è il confine a cui inevitabilmente la nostra vita è destinata, lo stesso indicarla come “buona” o “cattiva” non può che essere un’indicazione indebita: l’esperienza della morte in quanto morte, consegnata ad un silenzio senza ritorno, si sottrae a qualunque valutazione, rimane al di là dei nostri aggettivi. Si tratta allora di spostare l’aggettivo che l’eu greco indica, buono, dolce, “prima” dell’av-venire della morte, al processo del morire che conduce all’evento morte. L’interrogativo è allora: può il morire essere “buono/dolce” per l’esistente? cosa può renderlo tale?
La prima risposta, su cui non può che esserci consenso, è l’assenza del dolore, sia fisico che psichico. La seconda, implicita nella prima, è non un’assenza, ma una presenza: la presenza di qualcuno che sia vicino a chi attraversa il morire. Due condizioni che si intersecano: il dolore è, infatti, un’esperienza singolare [5] , di per sé ambigua, che isola l’esistente, dal momento che rimane sempre al di qua della possibilità del dire, della parola, è sempre e soltanto il “mio dolore”, ma, al tempo stesso, il dolore si fa domanda, invoca aiuto. Tra il silenzio e il grido, la domanda del dolore, dalla sua prima ancora inarticolata espressione nel “lamento”, segna il darsi di questa ambiguità. Così il dolore evidenzia con tutta la potenza del negativo, il volto duplice, ambiguo del nostro essere corpo-soggetto, insieme per-sé e per-altri [6] , un corpo che è il nucleo irriducibile della nostra personalità, mai completamente penetrabile all’altro, ma anche, necessariamente, per la sua stessa sopravvivenza, corpo-intenzionalità, che si tende all’altro, sin dal suo primo manifestarsi come bisogno/desiderio.
Nel processo del morire, là dove sempre più incalzante è la pretesa all’isolamento che la morte avanza all’Esserci[7], questa duplicità che segna il nostro essere corpo, e in particolare il nostro essere un corpo che soffre, si dà al massimo della tensione. Mai come nel processo del morire siamo soli, mai come allora avvertiamo che si tratta del “nostro corpo” che soffre e muore, e, al tempo stesso, mai come nel morire avvertiamo l’esigenza di avere qualcuno che ci sia vicino. E’ la profonda umanità del Gesù nel Getsemani: “L’anima mia è triste fino alla morte; restate qui e vegliate” (Mc, 14,33). L’angoscia di morte pretende che l’uomo Gesù sudi sangue e pianga nell’isolamento, ma, al tempo stesso, proprio per sottrarsi a quell’angoscia-isolamento l’uomo Gesù chiede ai suoi compagni di stare svegli e pregare. Sappiamo cosa accade: sappiamo come sia difficile stare svegli e accompagnare chi attraversa l’angoscia del morire.
Difficile, ma non impossibile, e, in ogni caso, necessario perché possiamo dire “buono/dolce” il morire. La presenza dell’altro è la condizione necessaria perché il dolore, quello fisico, ma anche quello psichico, il dolore dell’anima che con-fina sino a con-fondersi con l’angoscia di morte, trovi sollievo. Solo la mano dell’altro può con quel toccare che è il “primo” gesto terapeutico[8], dare sollievo al mio dolore. Solo la mano dell’altro, ma anche il suo sguardo, la sua voce, possono “curare” il mio dolore, sino a provare a rendere buono / dolce il mio morire.
Ma se tutto ciò è vero, per l’etica e per quella particolare forma di etica applicata che è la bioetica qui non ci sono problemi di principio, non c’è dilemma tra doveri che si contrappongono, ma solo la difficile strada dell’adempimento di un dovere su cui, da qualunque prospettiva, qualunque sia la nostra concezione della vita umana e del suo valore, non possiamo che convergere: rendere più dolce, o perlomeno meno aspro il percorrere l’ultimo tratto di strada. Qui semmai il problema che la bioetica si pone è quello, non di poca entità, di misurarsi sul “come” affrontare gli ostacoli che a quell’adempimento si frappongono, sulle scelte politiche ed economiche che devono attuarsi sulle allocazioni delle risorse perché quell’adempimento si traduca in pratica e non rimanga alle mere, vuote affermazioni di principio e di buona volontà. Non dimentichiamo quanto ancora separa i nostri malati terminali dalla possibilità concreta di una buona, efficace terapia del dolore, dalla possibilità di trovare su tutto il territorio strutture capaci di fornire cure palliative, dalla possibilità di un “ritorno a casa”, che sia sostenuto non solo dall’affetto dei familiari, ma anche dal supporto medico-infermieristico di una efficiente assistenza domiciliare.
Oltre gli sforzi in tal senso, che dovrebbero vedere una società civile coesa, al di là delle differenti posizioni ideologiche, rimane una differenza di fondo sull’interpretazione del “come” intendere la stessa lotta al dolore, le stesse cure palliative: una differenza che si riflette sulla stessa definizione di eutanasia[9].
Il senso comune non intende oggi l’eutanasia solo come la buona morte, la morte dolce, senza dolore, accompagnata dall’altro, ma l’intende piuttosto come la morte senza dolore e quindi buona, accompagnata, ma anche procurata intenzionalmente dall’altro. Vi è qui una differenza di fondo, su cui si accende da anni il dibattito bioetico: è lecito questo passaggio dall’accompagnare al procurare? E ancora, cosa si annida in questo nuovo significato dell’eutanasia come “procurare la morte”? E’ possibile comprendervi solo un procurare che ha a che fare con l’agire o anche un procurare che ha a che fare con l’omettere?
Per la Dichiarazione sull’eutanasia della Congregazione per la Dottrina della fede, l’eutanasia è “un’azione o un’omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore”[10]. Questa definizione, che troviamo ribadita in altri documenti della Chiesa cattolica come l’Evangelium vitae[11], comprende in sé sia l’eutanasia attiva che quella omissiva, non sempre e non da tutti considerata tale, come mostra il dibattito in corso nel nostro paese. Ha fatto discutere, infatti, la definizione di eutanasia data in un intervento sulla stampa in occasione del dibattito sul caso Welby, dal Cardinale Carlo Maria Martini: “un gesto che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte”[12]. Una definizione che ha avuto il merito, volutamente o meno, di mettere a nudo il vero punto nevralgico del dibattito bioetico italiano sulle questioni di fine vita: mentre l’eutanasia attiva incontra ostacoli nel nostro sentire morale comune, l’eutanasia omissiva rischia di superare le resistenze, confondendosi con la sospensione delle cure, fino a perdere la stessa identità di eutanasia. Il problema se la definizione di eutanasia comprenda in sé anche l’omissione delle cure eccede quindi l’ambito teoretico proprio delle definizioni dei concetti, diviene questione etica, mettendo in luce uno dei problemi più difficili nell’ambito delle scelte di fine vita: se e come si possa tracciare una distinzione eticamente rilevante tra “uccidere” e “lasciar morire”.
La definizione di eutanasia data dal Cardinale Martini viene considerata “insufficiente” da Mons. Elio Sgreccia, punto di riferimento della bioetica cattolica, per la buona ragione che “riguarda soltanto la cosiddetta eutanasia attiva, mentre è eutanasia anche la ‘omissione’ di una terapia efficace e dovuta, la cui privazione causa intenzionalmente la morte. In questo senso si realizza appunto l’eutanasia omissiva (non è appropriato chiamarla ‘passiva’, con un termine eticamente debole e neutro)”[13]. Una tesi condivisa, paradossalmente, per una singolare convergenza a partire da posizioni diametralmente opposte, da Umberto Veronesi, illustre rappresentante della bioetica laica: “tra un gesto che intende abbreviare la vita causando intenzionalmente la morte e la omissione di terapie la cui privazione causa intenzionalmente la morte la sostanza ed il significato morale non cambia”[14]. Una conclusione unica, pur se con conseguenze diametralmente opposte: l’eutanasia è sia attiva che omissiva e, quindi, sempre illecita, per la bioetica cattolica di Sgreccia; l’eutanasia è sia attiva che omissiva e, quindi, sempre lecita, per la bioetica laica di Veronesi. Per una e per l’altra visione l’omissione è eticamente equiparata all’azione per due motivi: il carattere intenzionale, il nesso causa-effetto.
Cosa rimane di mezzo? Rimane la difficoltà di comprendere se e come sia possibile parlare di una sospensione delle cure che non sia un’eutanasia omissiva, ovvero che non sia gravata da questi due segni che la caratterizzano, l’intenzione di morte e l’esserne direttamente causa.
E’ vero, infatti, che l’eutanasia come morte procurata dall’altro, per azione o omissione, il secondo senso che ritroviamo nella parola eutanasia, quello con cui la identifichiamo oggi, è sempre al confine col primo senso della definizione, quello su cui non ci sono problemi di liceità, l’eutanasia come morte buona, ovvero morte senza dolore e accompagnata. E ciò in due modi, che appaiono già chiaramente indicati nella Dichiarazione sull’eutanasia del 1980: la cura del dolore e la sospensione delle cure.
La terapia del dolore, di per sé assolutamente lecita, anzi doverosa al punto che la sua mancanza non può che essere uno “scandalo”[15], ha in sé un rischio su cui già da tempo le coscienze dei medici, in particolare degli anestesisti e rianimatori, si sono interrogate: fino a che punto spingersi con le dosi, là dove il dolore non cede e tuttavia la dose necessaria a liberare il paziente dal dolore rischia di accelerare la morte? E’ nota la risposta data da Papa Pio XII agli anestesisti e rianimatori già negli anni ’50, in un periodo che possiamo indicare come preistoria della bioetica[16].”Ad un gruppo di medici che gli avevano posto la seguente domanda:’ La soppressione del dolore e della coscienza per mezzo dei narcotici…è permessa dalla religione e dalla morale al medico e al paziente (anche all’avvicinarsi della morte e se si prevede che l’uso dei narcotici abbrevierà la vita)?’, il Papa rispose: ‘Se non esistono altri mezzi e se, nelle date circostanze, ciò non impedisce l’adempimento di altri doveri religiosi e morali: Sì”[17]. Una risposta coraggiosa, che rende lecito là dove se ne riscontri, in scienza e coscienza, la necessità e là dove la morte sia ormai prossima, correre il rischio di accelerarla per liberare il morente da un dolore insopportabile. In questo caso cosa ci mantiene al di là del confine con l’eutanasia attiva? I due criteri indicati prima: non c’è un’intenzione di morte, né c’è un rapporto necessario di causa ed effetto, tra il farmaco e la morte; quest’ultima può sopravvenire più rapidamente a causa del farmaco, ma è già causata, in modo irrevocabile ed ormai imminente, dalla malattia [18].
L’altro punto in cui i due sensi dell’eutanasia si ritrovano al confine, è quello che più ci interessa: la sospensione delle cure. Nella Dichiarazione si sostiene che il paziente ed il medico possono sempre sospendere le cure “sproporzionate”[19], sottolineando al tempo stesso che le cure “normali” devono essere mantenute[20]. Ma quali sono le cure “sproporzionate”, quali quelle “normali” e quindi non suscettibili di sospensione? Senza dolore e accompagnato dall’altro, l’ultimo tratto del mio vivere non può essere buono se mi vede ostaggio di cure che non hanno per me finalità alcuna. Emerge in questa distinzione tra proporzione e sproporzione delle cure un altro senso di un morire che sia buono, quello del morire “naturale”. Ma come possiamo tracciare il confine tra “natura” e “artificio”, oggi, nell’età della tecnica[21]? Come possiamo distinguere tra una medicina che sostiene la vita, sia pure con l’aiuto dell’artificio, a volte vistosamente evidente, e una medicina che impone il prolungarsi artificiale della vita? E’ possibile qui, ai confini della vita, recuperare la distinzione tra un’arte medica che sia per l’uomo e un artificio che sia sull’uomo[22]? Appare chiaro che questa distinzione, nella sua estrema difficoltà, non può che rinviare ad una “misura” della cura: è il suo carattere proporzionato o sproporzionato ciò che ci permette di distinguere l’arte dall’artificio, l’essere per l’uomo dall’ essere sull’uomo, o addirittura contro l’uomo stesso. Ma cosa accade se anche cure che sono di mero sostegno vitale appaiono sproporzionate al paziente o ai familiari che ne rappresentano l’interesse e la volontà?
Il problema si pone per la ventilazione e, in modo distinto, considerandole ancora più vicine alle cure “dovute” per la loro assimilazione alla cura base di ogni essere vivente, per l’idratazione e l’alimentazione. Il 27 giugno del 1981 il Pontificio Consiglio Cor Unum pubblica un documento Questioni etiche relative ai malati gravi e ai morenti, in cui si chiarisce “ l’obbligo stretto di proseguire ad ogni costo l’applicazione dei mezzi cosiddetti ‘minimali’. Di quelli cioè che normalmente e nelle condizioni abituali sono destinati a mantenere la vita ( alimentazione, trasfusione di sangue, iniezioni, ecc.). Interromperne la somministrazione significherebbe in pratica voler porre fine ai giorni del paziente”[23]. Questa posizione, più volte ribadita in discorsi ufficiali da Papa Giovanni Paolo II[24], viene ripresa anche dal pontificio Consiglio per la pastorale degli Operatori Sanitari nella Carta degli Operatori Sanitari: “L’alimentazione e l’idratazione, anche artificialmente amministrate, rientrano tra le cure normali dovute sempre all’ammalato quando non risultino gravose per lui: la loro indebita sospensione può avere il significato di vera e propria eutanasia”[25].
E’ evidente qui all’interno della fermezza con cui il principio della difesa della vita fisica viene ribadito contro l’eutanasia, in questo caso omissiva, l’apertura, del resto necessaria (ogni principio deve essere applicato e quindi interpretato), di un varco per l’interpretazione del principio stesso. Un’apertura all’interpretazione che – e forse è bene ricordarlo viste le tante critiche alla “rigidità” di una bioetica che si ispiri al Magistero della Chiesa – è anche e inscindibilmente attenzione alla persona del paziente, alla “gravosità” della cura dal suo punto di vista. Come sempre accade, ogni varco che si apre all’interpretazione richiede però, se non si vuole cadere nel mero relativismo, un di più di riflessione, una valutazione attenta di situazioni tra loro differenti. Il riferimento alla gravosità appare chiaramente giustificato quando si tratta di un paziente terminale, in cui la pratica dell’idratazione e alimentazione artificiale possono risultare particolarmente difficili, a volte invasive, proprio per le condizioni del malato ed arrecare scarso o nullo beneficio. Ma cosa accade se il paziente non è terminale e tuttavia giudica tali cure “gravose” per lui? E se le stesse cure risultassero sproporzionate secondo il giudizio dei familiari di un paziente in stato vegetativo, che si fanno portavoce di volontà precedentemente espresse dal paziente stesso? La loro sospensione può essere considerata eutanasia?
Mettiamo tra parentesi qui, volutamente, poiché richiederebbe una trattazione a parte, la questione della sospensione di cure di sostegno vitale su richiesta di un paziente capace, e vediamo come affrontare la seconda questione, ovvero la sospensione di tali cure su richiesta di familiari di pazienti in stato vegetativo persistente. La questione ci riporta indietro, alla distinzione tra azione ed omissione, tra “uccidere” e “lasciar morire”: una distinzione che, in tutta la sua problematicità, ritroviamo all’origine della bioetica. E’ il caso di Karen Quinlan, uno dei primi casi di bioetica, o meglio, uno dei casi che ha spianato la via alla nuova disciplina, mostrando la necessità di un confronto tra saperi diversi, scientifico, etico, giuridico. Nel 1975 Karen Quinlan, in stato vegetativo permanente, è mantenuta in vita col sostegno delle macchine. I genitori chiedono ed ottengono nel 1976 dalla Corte suprema del New Jersey l’autorizzazione alla disattivazione della ventilazione polmonare artificiale. In quanto rappresentanti legali della ragazza, i genitori credono di interpretarne la volontà e di agire nel suo migliore interesse. Tutto ciò è sufficiente per giustificare la loro richiesta? Secondo la giustizia dello stato del New Jersey, sì. Karen viene staccata dal respiratore, ma continua a vivere per circa dieci anni, alimentata e idratata artificialmente e sottoposta a cure antibiotiche[26]. Il caso successivo di Nancy Cruzan è apparentemente analogo: una paziente in stato vegetativo permanente, tenuta in vita mediante ventilazione, idratazione e alimentazione artificiali. Anche per lei i familiari chiedono la sospensione di tutti i trattamenti di sostegno vitale, non solo la ventilazione, come per la Quinlan, ma anche l’idratazione e l’alimentazione, ottenendo sentenza positiva nel 1990 dalla Corte suprema degli Stati Uniti, sulla base di testimonianze da parte di amici e parenti di volontà precedentemente espresse da Nancy[27]. Ancora, più di recente, nel 2005 il caso di Terry Schiavo accende il dibattito bioetico internazionale. La donna in stato vegetativo permanente è mantenuta in vita senza respiratore, solo col sostegno dell’idratazione e dell’alimentazione artificiale. Il marito chiede la sospensione di tali cure, mentre i genitori si oppongono. Alla fine viene autorizzato il distacco di idratazione ed alimentazione, ritenendo valide le prove che il marito porta a sostegno della volontà precedentemente espresse da Terry in merito alla condizione di vita in stato vegetativo. Come Nancy Cruzan, anche Terry Schiavo muore dopo alcuni giorni di agonia. Si è trattato dell’autorizzazione di un atto eutanasico di tipo omissivo o della sospensione di cure sproporzionate?
La questione non è di poca rilevanza se consideriamo la possibilità che anche nel nostro paese passi, come viene proposto da più parti[28], la validità legale del testamento biologico o delle dichiarazioni anticipate di trattamento[29]. In tali dichiarazioni non può rientrare alcuna disposizione che autorizzi l’eutanasia, vista la normativa vigente: la sospensione di trattamenti di sostegno vitale, rivolta a procurare la morte può essere considerata tale e quindi esclusa dalle volontà che possono essere espresse?
In tutti i casi su indicati, pur nella differenza delle singole situazioni abbiamo lo stesso problema di fondo: in Stati che non ammettono l’eutanasia attiva, viene tuttavia consentita la sospensione di trattamenti di sostegno vitale, una sospensione attuata con l’intenzione di procurare la morte e che non può avere altro effetto che la morte. Dopo le sentenze Quinlan e Cruzan si succedono negli Stati Uniti richieste di appello che mirano a far dichiarare incostituzionali le leggi degli Stati che vietano l’assistenza al suicidio in casi di pazienti adulti e malati terminali[30]. Le ragioni addotte si basano essenzialmente sull’equivalenza della sospensione di trattamenti artificiali di sostegno vitale e dell’assistenza al suicidio e sul rispetto della Clausola del 14 emendamento alla Costituzione statunitense, per cui tutte le persone in circostanze simili devono essere trattate in modo simile[31] . Al di là del dibattito giuridico, su cui non è nostra competenza entrare, rimane la difficoltà dal punto di vista etico di rispondere ai dubbi che da quel dibattito rimangono aperti: è possibile e come distinguere tra una sospensione di cure di sostegno vitale attuata per procurare la morte e l’eutanasia attiva? La sospensione di idratazione e alimentazione in soggetti in stato vegetativo permanente può essere giustificata come sospensione di cure ritenute, per “giudizio surrogato”[32], sproporzionate rispetto allo stato del paziente?
Sul versante etico, le Risposte date dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ai Quesiti della Conferenza Episcopale Statunitense circa l’alimentazione e l’idratazione artificiale, ripropongono alla riflessione e alla coscienza dei cattolici la fermezza del principio della difesa della vita fisica[33]e il dovere, da esso derivato, di mantenere le cure ordinarie e proporzionate che la sostengono: “La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel procurare l’idratazione e il nutrimento del paziente. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte dovute all’inanizione e alla disidratazione”[34].
Mentre la chiarezza dell’affermazione del principio impedisce che si attui la sospensione di idratazione e alimentazione per procurare la morte di pazienti in stato vegetativo, lo spazio lasciato all’interpretazione, alla valutazione ( “nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria”), evidenzia anche in questo documento come l’applicazione del principio abbia luogo sempre nel respiro della coscienza, nel suo difficile travaglio etico. Qualcosa di differente dal varco aperto all’eutanasia omissiva e, quindi anche, per una pericolosa deriva, sul versante dell’eutanasia attiva: tra l’uno e l’altro rimane, infatti, la differenza eticamente rilevante dell’intenzione e della responsabilità.
Torniamo al punto focale della distinzione tra uccidere e lasciar morire. Tale distinzione è stata “il primo punto di attacco alla posizione tradizionale da parte degli utilitaristi, i quali affermano che, ceteris paribus, un atto uccisivo diretto è moralmente equivalente all’omissione di un atto in grado di salvare la vita”[35]. Paradossalmente, oggi, tale distinzione, messa in crisi per mostrare la non illiceità dell’eutanasia, va ripensata, fino a metterla radicalmente in questione, da parte di una bioetica che ispirandosi al principio della difesa della vita fisica voglia evidenziare l’illiceità dell’eutanasia nella sua forma meno evidente, e quindi più pericolosa, l’eutanasia omissiva.
Occorre partire da un’ambiguità implicita nell’espressione “lasciar morire”, che comprende in sé significati eticamente diversi: il “far morire”, in cui l’omissione è rivolta intenzionalmente alla morte e ne è anche la causa diretta; il “permettere di morire”, in cui non vi è intenzione di morte, né connessione di causa ed effetto, ma solo una sospensione di cure che non hanno più alcuna efficacia, né sono di sostegno alla vita. La differenza è quindi su un doppio versante: quello dell’intenzione e quello della responsabilità, intesa nel senso dell’imputabilità o dell’essere causa di. Se è chiara la distinzione sul versante delle intenzioni, la distinzione sulla responsabilità connessa all’omissione è più soggetta ad ambiguità e necessita di ulteriori riflessioni sul potere connesso alla responsabilità. Io sono responsabile se ometto di compiere azioni che sono in mio potere e che hanno in sé il potere/la possibilità di salvare la vita. La distinzione tra un “far morire” gravato di responsabilità morale e un “permettere di morire” che è invece lecito, anzi doveroso, si gioca quindi non solo sul piano delle intenzioni, ma anche su quello del potere/possibilità di cura.
Siamo rinviati dunque dalla distinzione problematica di partenza all’interpretazione di una convinzione etica su cui tutti, anche a partire da opposte visioni sulla disponibilità/indisponibilità della vita, convergiamo: il no all’accanimento terapeutico o, se vogliamo alle cure sproporzionate. Dire accanimento terapeutico è, infatti, un dire qualcosa che è in se stesso contraddittorio: non c’è terapia là dove ci si accanisce, là dove si continua in cure non efficaci. La sproporzione delle cure rende meglio il concetto e, insieme, la difficoltà che in esso è insita cioè la difficoltà di trovare la “misura”[36]. Problema antico dell’etica e, in particolare, dell’etica medica, il problema della “misura” appare sempre più urgente nel momento in cui la medicina aumenta nel suo “potere di cura”. Accade che questo potere di cura si differenzi tragicamente dal potere di guarigione, capovolgendo la nuova forza in elemento di criticità. Una differenza che può darsi in due modi diversi: o perché rimane come un potere parziale, si può curare questo e quello, ma non si può guarire e nemmeno curare la persona, o perché rimane un potere limitato, anche se investe tutta la persona, si può sì “curarla”, o meglio “prenderla in cura” con un approccio olistico, ma non si può guarirla. Il problema etico si pone soprattutto quando le cure parziali, che la medicina può continuare ad offrire non convergono in una cura della persona, in un di più di benessere, di qualità e di quantità della vita della persona, ma si limitano a curare “questo” o “quel” male, consentendo non una guarigione, né un miglioramento della qualità della vita, ma un protrarsi della vita che a volte sembra mutarsi in un protrarsi di un processo del morire già avviato.
Ma, ancora, chi decide la misura, ovvero il limite della cura? Il paziente, il medico o entrambi? Sicuramente vi è un problema interno alla definizione delle cure sproporzionate, un problema che non riguarda solo la difficile interpretazione di ciò che è proporzionato, ma anche il soggetto che è deputato ad essere l’interprete più attendibile. La misura della cura, ovvero la risposta a cosa distingua un’arte medica che sia d’aiuto alla natura da un’ arte-artificio che forzi e costringa la natura, non può che passare dalla doppia interpretazione del paziente e del medico, là dove alla difficoltà insita nell’interpretazione soggettiva di un dato che si presume oggettivo, si aggiunge la difficoltà del confronto tra due interpretazioni che possono coincidere o divergere. Questo stare nel mezzo tra due interpretazioni, entrambe soggettive della cura, del suo carattere proporzionato o sproporzionato, è ciò che rischia costantemente di farci scivolare dal primo al secondo senso dell’eutanasia, da una morte buona, perché accompagnata e senza dolore, che sia vissuta il più possibile come compimento “naturale” della vita, a una morte procurata per omissione di cure proporzionate o ordinarie.
E’ necessario qui aprire una parentesi su un altro punto fondamentale nella questione bioetica dell’eutanasia. Interpretata come una questione che rimanda alla grande tematica della disponibilità o indisponibilità della vita, l’eutanasia è spesso difesa come una “questione di libertà”[37]. Questa impostazione vede il problema etico solo dalla parte di chi richiede l’eutanasia, non vede il problema etico di chi accetta la richiesta di morte. Non si tratta, come vuole Jankélévitch, di spostare il problema dal paziente che vuole morire, al medico a cui la morte viene richiesta[38]. L’eutanasia non è solo un problema del medico, così come non è solo un problema del paziente, ma è un problema del paziente e del medico, della loro relazione. Una relazione solo apparentemente a due, in realtà molto più complessa: al suo interno si inseriscono dei terzi, che possono essere identificati come i familiari, o gli altri operatori sanitari; all’esterno agiscono sulla relazione come cause positive o negative le dinamiche della struttura ospedaliera, del sistema sanitario, del sistema socio-politico. Possiamo dire che l’eutanasia non è solo un problema del paziente e del medico, ma che è un problema del paziente, del medico e della società. Dicendo che l’eutanasia si dà in un contesto di relazione, che è un problema di relazione[39], spostiamo l’asse della riflessione da un’attenzione esclusiva all’autonomia del soggetto, e ai suoi limiti, se comprenda o meno al suo interno la disponibilità della vita, ad un’attenzione che fa centro sulla responsabilità[40] o meglio sulle responsabilità dei vari soggetti a più livelli coinvolti nella relazione di cura.
Ora tutto questo ritorna dalla tematica generale dell’eutanasia alla tematica particolare dell’eutanasia omissiva e alla sua difficile, problematica distinzione dalla sospensione delle terapie sproporzionate. Impostare il problema dell’eutanasia come problema non solo di autonomia, ma anche e soprattutto di relazione significa, anche su questo versante, ripensare il giudizio sulla misura o, se vogliamo, sul limite delle cure come un problema che si dà all’interno della relazione di cura, ma anche vigilare su tutti i fattori che all’interno e all’esterno della relazione possano influire sul giudizio stesso, fino a metterne in crisi la serenità.
La possibilità di distinguere all’interno del giudizio sulla misura delle cure, due prospettive, che possiamo indicare come la prospettiva, in cui prevale il giudizio del medico e quella in cui prevale il giudizio del paziente [41], o di chi lo rappresenta, può infatti, costituire un forte momento di criticità nella difficile valutazione se si tratti o meno di una sospensione di cure sproporzionate, e quindi, di “permettere di morire”, o dell’omissione di cure proporzionate, e quindi di “far morire”.
E tuttavia, nonostante i rischi di criticità, la doppia interpretazione del paziente e del medico è un passaggio essenziale per il giudizio, spesso difficile, sulla misura delle cure. Nella Dichiarazione sull’eutanasia, nella parte dedicata all’uso proporzionato di mezzi terapeutici leggiamo: “in molti casi la complessità delle situazioni può essere tale da far sorgere dei dubbi sul modo di applicare i principi della morale. Prendere delle decisioni spetterà in ultima analisi alla coscienza del malato o delle persone qualificate per parlare a nome suo, oppure anche dei medici, alla luce degli obblighi morali e dei diversi aspetti del caso”[42].
Tutti e due i giudizi, del medico e del paziente o di chi lo rappresenti, sono nell’ottica della relazione, essenziali. L’uno deve confrontarsi con l’altro, se si vuole evitare il doppio rischio di un giudizio che pretenda ad un’oggettività in cui sia negato spazio alla soggettività del paziente, o di un giudizio meramente soggettivo, in cui la soggettività del paziente sia lasciata a se stessa. La possibilità di integrare i due giudizi sulla “misura” della cura è la scommessa di un’alleanza terapeutica riuscita, il cui ordito paziente e medico devono pazientemente ritessere dall’inizio della cura sino ai confini della vita. Un’opera di tessitura non facile, sempre esposta, come dicevamo al rischio di influenze esterne, così come del resto non è facile la pratica dell’alleanza terapeutica, su cui grava, anche per quelle influenze, soprattutto ai confini della vita, l’ombra negativa della possibilità dell’abbandono o della “negligenza terapeutica”[43].
La responsabilità del giudizio sulla misura delle cure ricade, quindi, non solo sul medico e sul paziente, sulla loro difficile relazione, ma su tutti coloro che sono chiamati a compiere scelte socialmente rilevanti sulla cura dei pazienti terminali. Una responsabilità pesante poiché si tratta di decisioni da prendere muovendosi sempre su uno stretto asse di equilibrio: tra il sostegno della vita e il protrarsi del processo de morire, tra la sospensione di cure ormai inutili e il procurare, sia pure per omissione, la morte. Perdere l’equilibrio, o smettere di cercarlo, significherebbe incrinare non solo l’alleanza terapeutica, capovolgendone il fine primario, la cura della vita, ma anche indebolire il caposaldo di quella più ampia alleanza che ci consente di vivere insieme come uomini tra uomini: il rispetto della vita di ogni essere umano.
* Professore Associato di Bioetica all’Università di Messina e Membro del Comitato Nazionale di Bioetica
[1] Cfr. J. V. GOFF, Pensare l’eutanasia (2004), tr. it. A Serafini, Giulio Einaudi editore, Torino 2006.
[2] Cfr. J.M. COOPER, Greek Philosophers on Eutanasia and Suicide, in B.A. BRODY (ed.) Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht/Boston/London, 1989, pp. 9-38; R. BARCARO, Eutanasia, Franco Angeli, Milano 1998, p. 27 e sg.; M. REICHLIN, L’etica e la buona morte, Edizioni di Comunità Torino 2002, p. 5 e sg.
[3] Cfr. M. HEIDEGGER, Che cos’ è la metafisica?(1929), tr. it. a cura di A. Carlini, La Nuova Italia, Firenze 1984.
[4] Sul sapere e la morte cfr. C. SINI, Irrazionalità e morte, in AA. VV., La morte oggi, a cura di M. Spinella, G. Cassanmagnago, M. Cecconi,Feltrinelli, Milano 1985,pp. 69-76.
[5] Cfr. S. NATOLI, L’esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano 1992.
[6] Cfr. U. GALIMBERTI, Il corpo, Feltrinelli, Milano 1994.
[7] Come scrive Heidegger, “la morte pretende l’esserci nell’isolamento”(Essere e tempo (1927), tr.it. a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1969, p. 394).
[8] Cfr. V.v. WEIZSACKER, Filosofia della medicina, a cura di T. Henkelmann, tr.it. L. Bottani, G. Massazza, Guerini associati, Milano 1990, pp. 97-98. Sulla mano e la cura cfr. H. G. GADAMER, Dove si nasconde la salute, ed. it. a cura di A. Greco e V. Lingiardi, Raffaello Cortina Editore, Milano 1994, p. 110 e 118-119.
[9] In genere, con la sola esclusione dell’Olanda “in seno alle cure palliative abbreviare intenzionalmente la vita di un malato viene condannato come un gesto immorale” (B. GORDIJN, Cure palliative e prevenzione dell’eutanasia attiva, in S. PRIVITERA (a cura di), Vivere ‘bene’ nonostante tutto, Le cure palliative in Italia e in Europa, Edizioni dell’Istituto Siciliano di Bioetica, Acireale, 1999, p. 66. Per il Comitato Nazionale per la Bioetica, le cure palliative, “poiché si propongono come obiettivo il mantenimento di una accettabile qualità della vita anche nella sua fase terminale” appaiono come “ la migliore risposta possibile ad una eventuale richiesta di eutanasia” (Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, 14 luglio 1995).
[10] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione sull’eutanasia, 5.5.1980,II, http://www.vatican.va.
[11] GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, 25.3. 1995, http://www.vatican.va.
[12] Cfr. l’intervento del Cardinale Carlo Maria Martini apparso sul “Sole 24 ore” del 21.1.2007.
[13] Cfr. l’intervento di E. Sgreccia apparso sul “Corriere della sera”, 23.1.2007.
[14] Cfr. l’intervento di U. Veronesi apparso sullo stesso numero del “Corriere della sera”.
[15] Cfr. S. NULAND, Davanti alla morte, tr. it. di S. Liberatore, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 20.
[16] Cfr. G. RUSSO (a cura di), Storia della bioetica, Armando editore, Roma 1995, p. 12 e sg.
[17] PIO XII, Allocutio, die 24 feb. 1957: AAS 49 (1957) 147, ripreso in Dichiarazione sull’eutanasia,III.
[18] “In questo caso, infatti, è chiaro che la morte non è voluta o ricercata in alcun modo, benché se ne corra il rischio per una ragionevole causa: si intende semplicemente lenire il dolore in maniera efficace, usando allo scopo quegli analgesici di cui la medicina dispone” (Dichiarazione sull’eutanasia, III).
[19] Nella Dichiarazione si preferisce sostituire alla dizione “mezzi straordinari” usata precedentemente dai moralisti, quella di “mezzi sproporzionati”, che rinvia più chiaramente agli elementi essenziali per la valutazione morale: il confronto tra il tipo di terapia, le difficoltà, i rischi, i risultati attesi , le condizioni e la forza fisica e morale del paziente ( cfr. IV).
[20] “Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi” (Dichiarazione sull’eutanasia, IV).
[21] E’ la domanda difficile e sofferta, dalla cui difficoltà e dalla cui sofferenza non ci è dato evadere, posta da Pier Giorgio Welby: “che cosa c’ è di ‘naturale’ in una sala di rianimazione? Che cosa c’è di naturale in un buco nella pancia e in una pompa che la riempie di grassi e proteine? Che cosa c’è di naturale in uno squarcio nella trachea e in una pompa che soffia aria nei polmoni? Che cosa c’è di naturale in un corpo tenuto biologicamente in funzione con l’ausilio di respiratori artificiali, alimentazione artificiale, idratazione artificiale, svuotamento intestinale artificiale, morte-artificialmente-ritardata?” (P. WELBY, Lasciatemi morire, Rizzoli, Milano 2006, p. 11).
[22] E’ la difficile distinzione su cui riflette, tra gli altri, Bruguès, tra un’arte che “costruisce l’umano” e un artificio che “lo corrompe”: “Davanti ad una tecnica qualsiasi , l’uomo si sforzerà di ‘leggere’: se questa tecnica risponde ad un bisogno la cui soddisfazione fa crescere l’uomo in dignità, egli la considera come moralmente ammissibile (l’arte produce l’umano). Se invece, la soddisfazione del bisogno colpisce in lui una finalità superiore, la tecnica sarà classificata come artificio, dunque, a questo titolo, inammissibile”( J. L. BRUGUES, Fecondazione artificiale: una scelta etica? (1989), tr.it. M. Vecchietti, SEI, Torino 1991, p. 82).
[23] PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM, Questioni etiche relative ai malati gravi e ai morenti, 27.6.1981, http://www.academiavita.org.
[24] cfr. Discorso ai partecipanti ad un Corso internazionale di aggiornamento sulle plurileucemie umane, del 15 novembre 1985; Discorso ad un gruppo di Vescovi degli Stati Uniti in visita ad limina del 2 ottobre 1998, Discorso del 20 marzo 2004 rivolto ai partecipanti ad un Congresso internazionale su “ I trattamenti di sostegno vitale e lo stato vegetativo. Progressi scientifici e dilemmi etici” , http://www.vatican.va, n. 2.4.4.
[25] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER GLI OPERATORI SANITARI, Carta degli operatori sanitari, Città del Vaticano 1995, http://www.vatican.va, n. 120.
[26] Cfr. In re Quinlan,70 N.J.10.355 A. 2d 647 (1976),at 663-64; cfr. T.L. BEAUCHAMP, J.F. CHILDRESS, Princìpi di etica biomedica (1994), ed. it. a cura di F. Demartis, Casa editrice Le Lettere, Firenze 1999, passim.
[27] Cfr. In Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 110, S.Ct.2841 (1990); cfr. T.L. BEAUCHAMP, J.F. CHILDRESS, Princìpi di etica biomedica, passim.
[28] Cfr. M. DE TILLA, L. MILITERNI, U. VERONESI (a cura di),I Il testamento biologico, Sperling & Kupfer Editori, Milano 2007.
[29] Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Dichiarazioni anticipate di trattamento, 18.12.2003, www.governo.it/bioetica/pareri. Vedi anche: P. CATTORINI ( a cura di), Le direttive anticipate del malato, Masson, Milano 1999; P. SOBBRIO, Il rapporto paziente medico alla luce del parere del CNB sulle direttive anticipate di trattamento, in M. GENSABELLA FURNARI (a cura di ), Il paziente, il medico e l’arte della cura, a cura di M. Gensabella Furnari, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; S. AMATO, Le dichiarazioni anticipate di trattamento, in COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Il Comitato Nazionale per la Bioetica 1990-2005. Quindici anni di impegno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma 2005; vedi anche Dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, Raccolta di contributo forniti alla commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica aggiornata al 21 febbraio 2007, Senato della Repubblica, Roma 2007, Documentazione di commissione n. 5 ( v. www.senato.it)..
[30] Cfr. R. BARCARO, Eutanasia, pp. 94 e sg.; V. POCAR, Le sentenze americane sull’assistenza al suicidio, in “Bioetica” 1996, n. 3 , pp. 523-542.
[31] Cfr. R. BARCARO, Eutanasia, p. 95.
[32] Cfr. T.L. BEAUCHAMP, J.F. CHILDRESS, Princìpi di etica biomedica, p. 175.
[33] Su tale principio vedi: E. SGRECCIA, Manuale di bioetica,Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 160-163.
[34] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposte a quesiti della Conferenza Episcopale Statunitense circa l’alimentazione e l’idratazione artificiali, http://www.vatican.va.
[35] M. REICHLIN, L’etica e la buona morte, p. 72. Si vedano su questo le posizioni di: M. TOOLEY, An irrilevant consideration. Killing versus letting die, in B. STEINBOCK (ed), Killing and Letting Die, Prentice Hall, Englewood Cliffs N.J. 1980; J. RACHELS, La fine della vita (1986), tr.it. Sonda, Torino 1989. Su posizioni diversamente articolate e che prendono avvio da differenti orientamenti, ma sempre rivolte a mettere in discussione la distinzione tra “uccidere”e “lasciar morire”, cfr.: H. KUHSE, The Sanctity-of-Life Doctrine in Medicine. A Critique, Clarendon Press, Oxford 1987; T. L. BEAUCHAMP, J.F. CHILDRESS, Princìpi di etica biomedica; D. NERI, Eutanasia, Laterza, Roma-Bari 1995.
[36] Sulla centralità del problema della “misura” in tutte le questioni bioetiche, mi permetto di rinviare a quanto ho scritto in Tra autonomia e responsabilità. Percorsi di bioetica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, Prefazione.
[37] D. NERI, Eutanasia:le ragioni del sì, in M. GENSABELLA FURNARI (a cura di), Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 81.
[38]“Chi vuol darsi la morte, se la dà – dopo si fa un’inchiesta, ed è tutto. Ma il problema dell’eutanasia è la libertà per il medico di far morire, direttamente o indirettamente, un malato il cui stato è giudicato disperato, con l’accordo del malato stesso. È questo il problema dell’eutanasia: il diritto legale per il medico – che secondo la lettera del diritto apparirebbe come un omicida – di fare al malato l’iniezione mortale liberatrice. Freud, per esempio, malato a morte, colpito da un orribile cancro al volto, che chiede a un amico l’iniezione in grado di liberarlo dagli ultimi tormenti. Ma il problema dell’eutanasia si pone per il medico – non per Freud. Perché per questi si riduce al problema del suicidio” (V. JANKÉLÉVITCH, Pensare la morte?, tr. it. E. Lisciani-Petrini, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995, p. 62). Possiamo notare che anche nel caso di Freud la domanda di eutanasia viene rivolta a partire da una relazione amicale, sulla base di un patto stretto tra Freud e il “suo medico” sin dall’inizio della malattia (cfr. P. GAY, Freud, Una vita per i nostri tempi, tr.it. di M. Cerletti Novelletto, Bompiani, Milano 1988, p. 591).
[39] Mi permetto di rinviare a quanto ho scritto in: Eutanasia: una questione di relazione, in “Medicina e Morale”, n. 6, 2007, pp. 1187-1215.
[40] Cfr. L. ALICI, Etica ed eutanasia: l’orizzonte della responsabilità, in Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire, vol. 2°, pp. 217-242.
[41]Un motivo di criticità è dato dalla possibilità di distinguere all’interno dell’accanimento due prospettive, che possiamo indicare come la prospettiva, in cui prevale il giudizio del medico e quella in cui prevale il giudizio del paziente. E’ possibile, infatti, distinguere tra: “terapie sproporzionate per eccesso”, definite come tali a partire dal giudizio clinico del medico curante, formulato sulla base di conoscenze scientifiche, linee guida e protocolli operativi applicati al singolo caso clinico; “terapie insopportabili”, ritenute troppo gravose dal paziente, indipendentemente dal giudizio clinico di efficacia e che potrebbero essere o direttamente oggetto di rifiuto, o portare il paziente al rifiuto di tutte le cure (distinzione tratta da un colloquio con il Prof. Rodolfo Proietti, Direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica).
[42] Dichiarazione sull’eutanasia, IV. Nello stesso senso, ma con una accentuazione del ruolo del medico, va quanto scritto a proposito della liceità dell’interruzione dei mezzi messi a disposizione dalla medicina più avanzata: “nel prendere una decisione del genere, si dovrà tener conto del giusto desiderio dell’ammalato e dei suoi familiari, nonché del parere di medici veramente competenti; costoro potranno senza dubbio giudicare meglio di ogni altro se l’investimento di strumenti e di personale è sproporzionato ai risultati prevedibili e se le tecniche messe in opera impongono al paziente sofferenze e disagi maggiori dei benefici che se ne possono trarre” (ibidem).
[43] Cfr. il già citato intervento del Cardinale Martini sul “Sole 24 ore”.